Urla di festa, profumo di fragola e lingue rosse: un giorno di svago all’Aina Children Home
Posted at 10:02h in Storie 0 Commenti
Oggi all’Aina Children Home è un giorno di svago. Il sabato si frequenta la scuola solo al mattino e i bambini e i ragazzi hanno più tempo libero. I momenti di gioco si alternano alle responsabilità: si fa la doccia, il bucato e le camere vengono fatte arieggiare. I più piccolini ne sono esenti, ma i più grandi (dagli 8 in su) devono dare una mano. I vestiti vengono stesi tutti insieme all’aperto ed ogni capo ha un numero (che indica l’età, ad esempio 7 anni) o il nome del bambino o del ragazzo, scritto all’interno con un pennarello indelebile. I vestiti vengono raccolti e portati in una grande stanza e i ragazzi stessi li smistano: nursery, boys, girls. Do loro una mano e quando raccogliamo le mutande sono grosse risate. È un momento per fare conoscenza.
Quanti anni hai? In Italia c’è il nome Wendy? Milden? Kanana?
Cosa ti piace mangiare? Ti piace la pizza? E i fagioli? Sei stata in Canada? E in Giappone?
Tu sembri indiana con questi capelli!
I capelli lunghi sono incredibili da guardare e da toccare per le ragazze, che portano i capelli rasati per una questione prettamente igienica. Vengo assalita da decine di ragazzine che si improvvisano acconciatrici, litigano tra di loro per chi deve avere l’onore di farmi una treccia. Tutto ciò che sta in testa crea stupore: forcine, elastici, pinze. E gli orecchini sono una chicca che alcune ragazze devono ancora assaporare.
I maschietti invece mi accompagnano a fare un giro alla fattoria. Conoscono l’albero genealogico di tutti gli animali presenti. Questo maiale è la mamma di questo, di questo e di questo. Poi ci sono i vitellini, Come to see, take a picture! Ai bovini sono stati dati nomi di persone conosciute dai bambini, tra cui la coordinatrice del villaggio, una ragazza romana di 25 anni che i ragazzi amano e rispettano come un capofamiglia.
È importante che io salga su un gruzzolo di terra per vedere l’uovo appena fatto dalla gallina. Poi si corre tutti verso il cancello, qualcuno ha portato dei lecca lecca. Urla di festa, profumo di fragola e lingue rosse.
Trascorrere il tempo qui a ‘Nchiru vuol dire svegliarsi la mattina appena sorge il sole poiché non ci sono le tapparelle alle finestre, salutare gli agricoltori che armati di stivali e attrezzi si muovono come degli omini Lego; attendere che i tre piccoli del villaggio, Victor, Christine ed Angel si accorgano che siamo nei paraggi per vederli correre verso di noi, ridendo a crepapelle; aspettare l’ora della merenda così da dare il cinque a tutti i bambini e ragazzi che si recano in sala mensa, con le loro uniformi, talvolta rattoppate; respirare aria fresca, quella che ti è mancata per gran parte dell’anno lavorativo e dei weekend; sai che durante la giornata ti toccherà almeno un ban, un tiro a canestro, un abbraccio (dato e ricevuto), un sorrisone bianchissimo, un animale poco gradevole che occuperà i tuoi spazi, una doccia che in realtà è una battaglia con l’acqua che non c’è o con lo scarico tappato.
Dopo aver colorato e disegnato con i bimbi della nursery, una scena che mi ha toccato: i bambini messi in fila, pronti col bicchierone d’acqua a buttare giù con un sorso i farmaci. Prince apre grande la bocca per far vedere alla housemother di averle realmente prese.
Un pensiero stupido, probabilmente, perché quei farmaci permettono loro le cure necessarie, e la vita. Credo che mi abbia commosso quella diligenza, il rispetto della fila, la piccola Elaine che aiutava a sistemare i portapillole, una routine quotidiana che però mi tocca e mi commuove mettendolo per iscritto.
Su alcuni letti dei dormitori ci sono dei pupazzi, sgualciti, ma teneri. Il pupazzo in psicologia viene descritto come l’oggetto transizionale che sostituisce in qualche modo la madre, prima di distaccarsene completamente. Qui ascolto delle storie di sofferenza, di madri e padri che non ci sono più; a volte ci sono degli zii, una nonna; a volte non c’è nessuno. Ciononostante, i bambini qui sono al sicuro, vengono nutriti e curati. Il villaggio di Aina è un faro nel buio.
I bambini africani crescono in fretta, non potrebbe essere altrimenti. Gli educatori svolgono un lavoro fantastico e preparano grandi e piccoli alla vita, perché Aina un giorno finirà per loro, e dovranno essere forti e in gamba, anche se il villaggio resterà per sempre una grande famiglia per loro, come per Mutuma, 25enne, studente universitario e che in questi giorni passa da qui, a trascorrere un po’ di tempo al villaggio.
Ogni 15 del mese al villaggio Aina si festeggiano tutti i bambini nati nel mese corrente. Una modalità che permette di fare una festa per tutti: 130 feste di compleanno non possono essere sostenute. Per cui si sceglie un menù diverso dal solito: stasera patate al forno e pescegatto fritto. Da bere succo di ananas:
l’ananas viene fatta bollire in modo da estrarre l’intero succo. E una grande torta. I bambini sono euforici, urlano e cantano. I visi neri si riempiono di zucchero a velo e le mani sono appiccicose. Anche noi ci lasciamo trasportare da questo momento di grande festa, battendo le mani sui tavoli e sulle panche, dando vita a piccole coreografie. I festeggiati si riuniscono davanti alla torta e tutti insieme ne danno il primo taglio. Non ci sono regali, non ci sono palloncini. L’attenzione non è sul singolo, ma sempre sulla comunità, anche in questo caso, anche nel giorno, anzi, nel mese, del proprio compleanno.
Le giornate trascorrono così, tra doveri e piaceri, iniziano sbucciando piselli sotto un cielo grigio e terminano con un caldo sole, tra i sorrisi e i canti dei 130 bambini e ragazzi che vivono all’Aina Children Home, poiché orfani o figli di genitori troppo poveri che, per assicurare loro una vita e delle cure migliori, hanno fatto una scelta difficile, per amore. Lo stesso amore che loro sanno donare.
Dopo una giornata piena mi ritrovo un po’ malinconica. Il pensiero fa un salto in avanti, come un grillo deciso, pensando al dopo, al ritorno. Inutile descrivere il varco che ti si apre nel petto. Ma il grillo si trasforma subito in un gambero: fa un passo indietro e ti riporta alla realtà, quella africana, questa. Il presente.
Credo sia questo quello che conti: “presente”, come ci è stato insegnato, vuol dire anche regalo.
Alla fine del viaggio, se si potesse contare quante teste abbiamo accarezzato, quante mani abbiamo stretto, quanti abbracci abbiamo donato, quanti baci dolcemente dato, in quanti sorrisi la nostra bocca si è allargata, quanti occhi abbiamo incrociato, quanto abbiamo corso e rincorso, saltato, quante altalene spinte, e quanti vola-vola volato, quanti vestiti abbiamo piegato, quanta terra rossa abbiamo sollevato, quanta aria fresca abbiamo respirato, quanti Ciao e Jambo con la mano abbiamo pronunciato… tutto questo ha un valore inestimabile. Ho realizzato il sogno della mia vita venendo qui, sono venuta “a casa loro”, e ho trovato sorrisi grandi quanto la loro povertà, e una capacità di resilienza che un occidentale dopo tre giorni sarebbe impazzito. I loro movimenti, il modo di versare il the mischiato con il latte, di portare i sacchi di patate, di ballare a ritmo, di camminare con i bambini dietro la schiena, di sorridere, sempre, di staccare le verdure dalla terra, di acconciarsi i capelli, di indossare abiti poco abbinati e di stagioni diverse restando pur sempre affascinanti, di camminare con scarpe più grandi. Questa solo una piccola fetta di tutto ciò in cui ci siamo calate in questi giorni, con tutte le scarpe e con tutto il cuore. Ringraziare sempre, ad ogni complimento o melanzana ricevuta.
Se chiudo gli occhi, vedo un rullino di immagini meravigliose.
Nell’ultimo vola vola, abbraccio e respiro Kanana, lei, uno dei primi sorrisi che mi ha subito colpito.
Asante sana






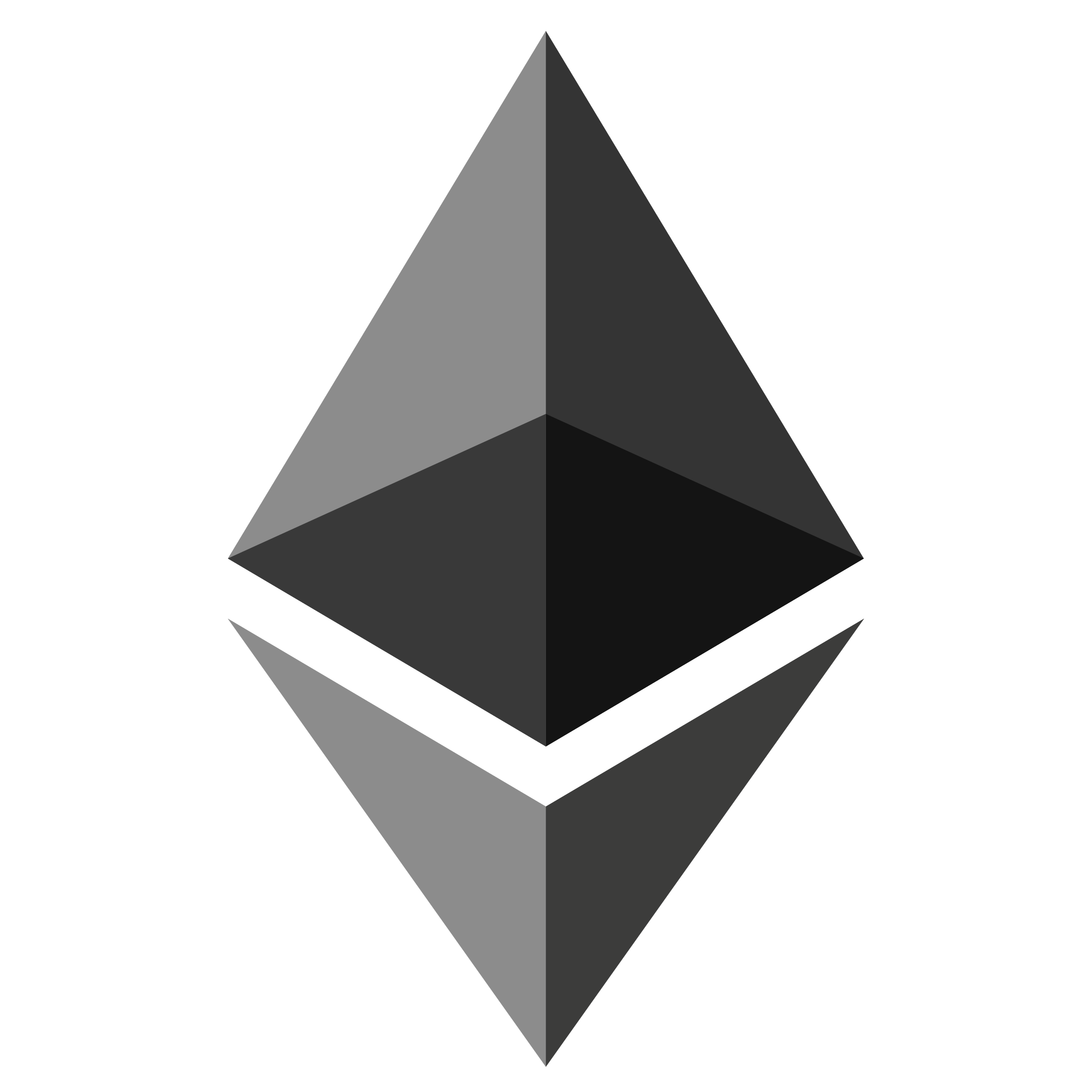

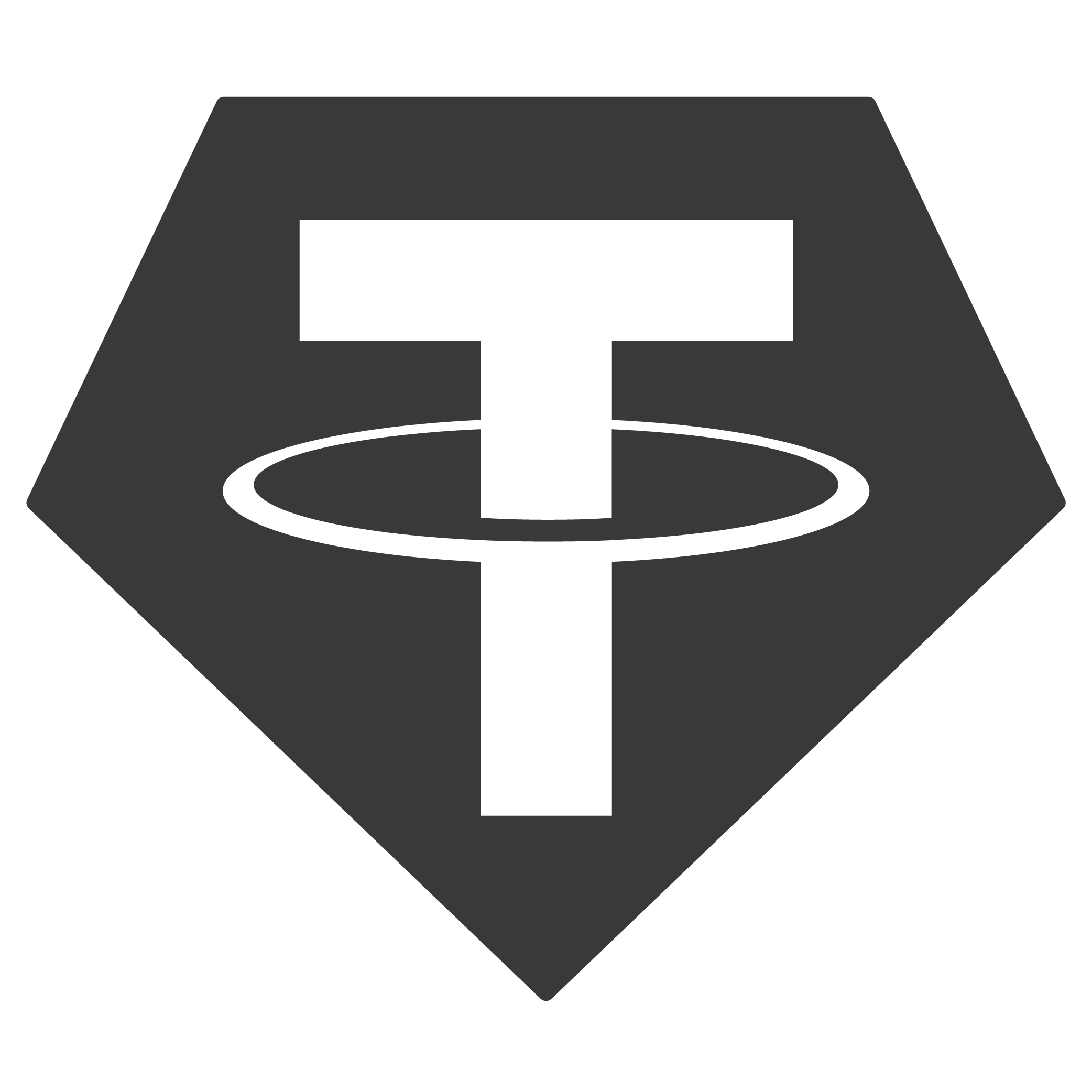
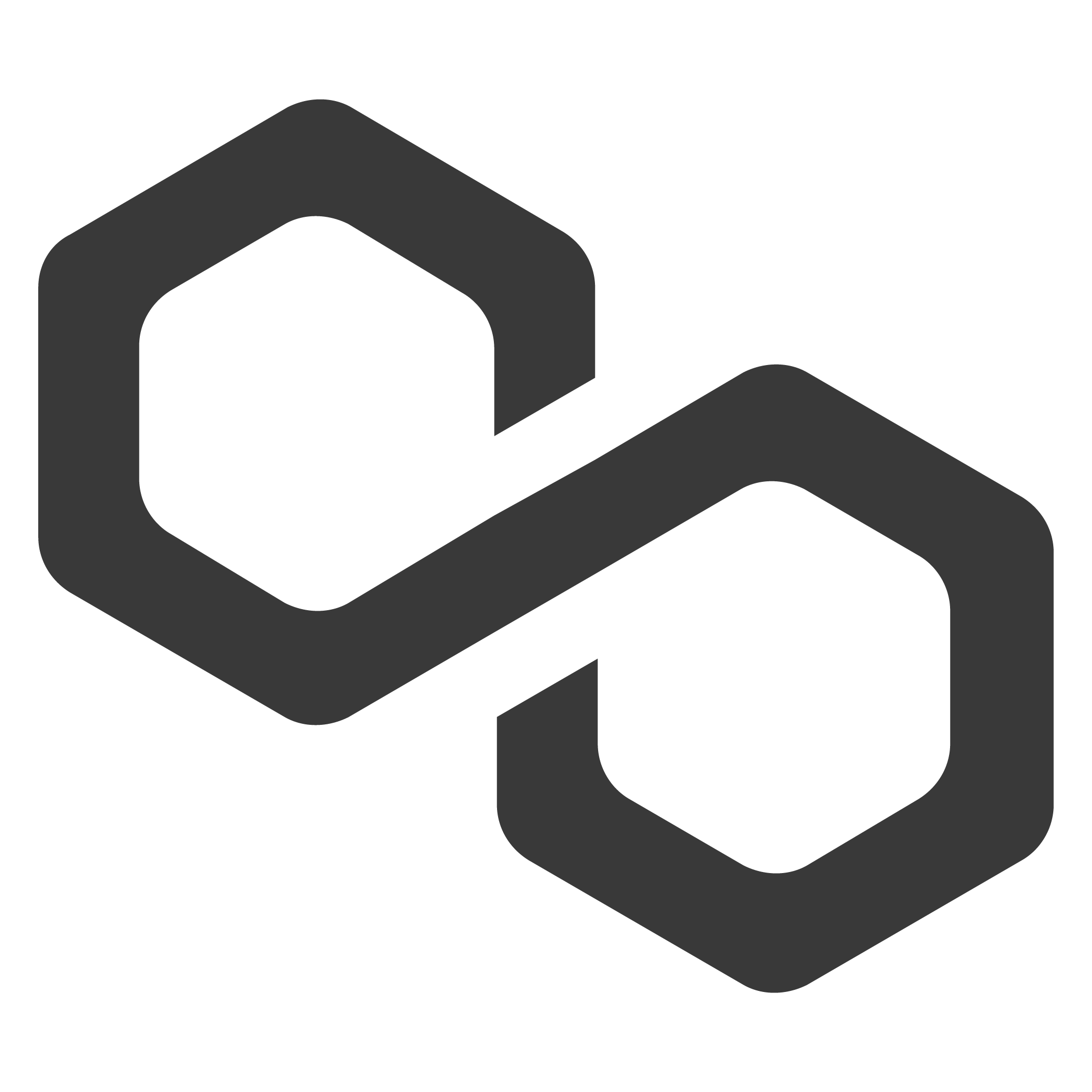
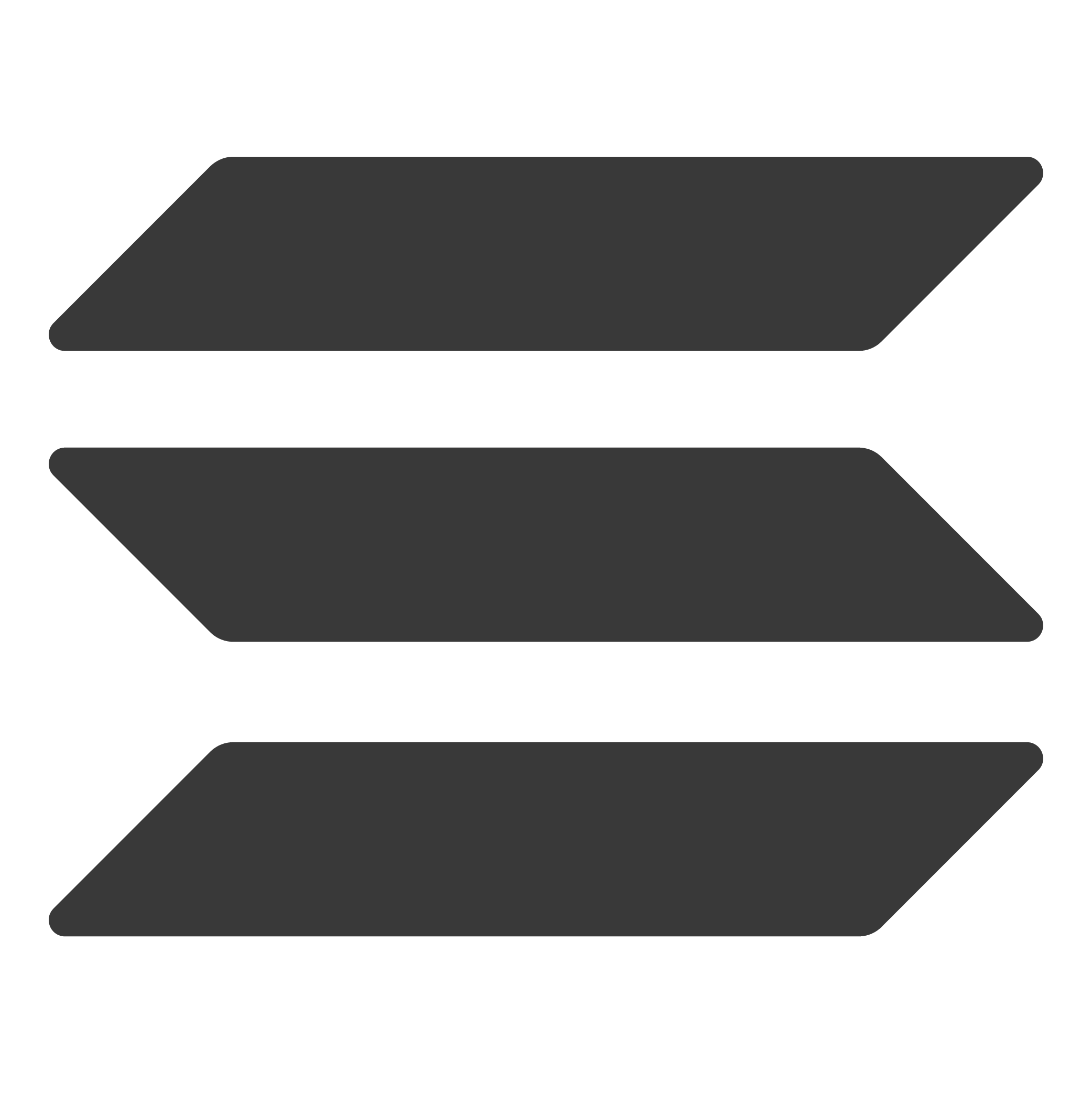
Nessun Commento